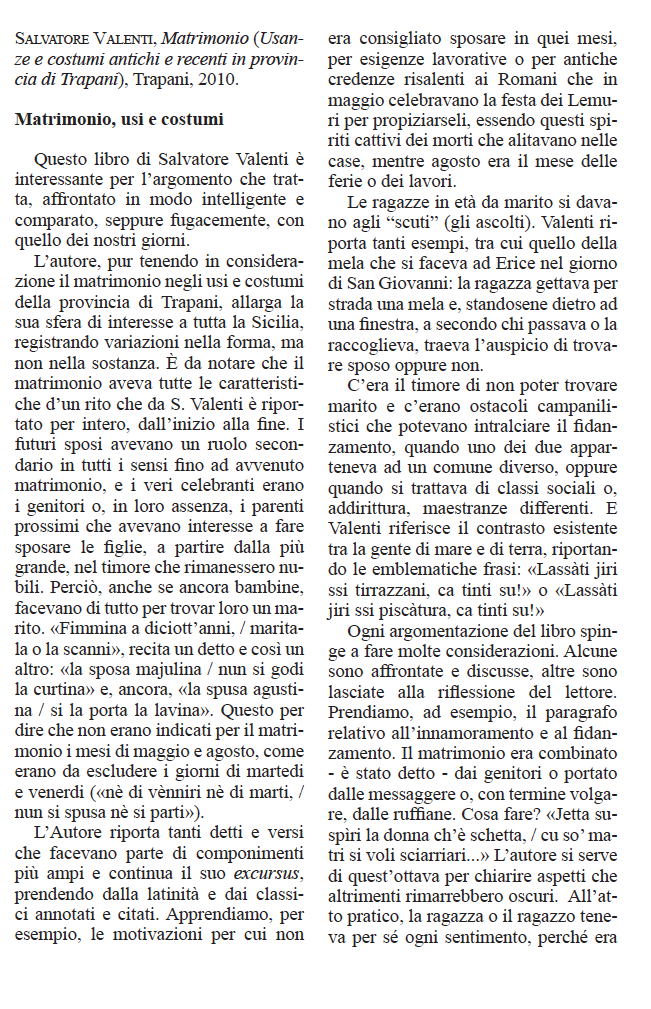Romano Cammarata ha esordito nella poesia con la fortunata silloge Per dare colore al tempo (1), anche se egli nasce alla poesia con la prosa di Dal buio della notte (2). Era da poco uscito da un labirinto di dolore fisico, aveva cominciato a rigustare il sapore della vita e, di qui, il magma, che gli era rimasto a lungo dentro, si sprigiona per prendere forma e ridare fiducia a quanti nel dolore navigano.
Possiamo inoltrarci nella poesia di Romano Cammarata partendo, perciò, dalla sua prosa e anche dai lavori in rame sbalzato o, ancora, dalla fotografia, che tanto vuoto gli avevano riempito durante le lunghe degenze e le noiose convalescenze. Solo allora possiamo bene comprendere l’uomo e il poeta.
Poeta, secondo la filologia sperimentale di Davide Nardoni, è «colui che qualifica». Romano Cammarata è un gran qualificatore di sé per gli altri. Altrimenti, non avrebbe senso la poesia. Sarebbe sempre qualcosa di bello, ma fredda, e non direbbe niente; l’impegno, invece, le dà vigore e l’infiamma. E se questo lo riscontriamo in tutta la produzione artistico- letteraria, tanto più lo notiamo nei suoi ultimi componimenti poetici, che costituiscono di certo il più bel testamento umano e spirituale che abbia potuto lasciarci.
Nelle poesie apparse in «Spiragli » nel 1992 (3), e mai prima d’ora raccolte in volume (Un sogno, Magellano ’90, Chi sono? Tempo presente, Ho sognato i miei sogni, Fantasmi a Milano, che nella registrazione Cammarata intitola Via Commenda, a Milano), c’è un sentito bisogno di evasione, ma anche il richiamo ad una realtà sempre più grigia.
Il poeta vive le aspettative d’un mondo di pace nella concordia e nel rispetto di tutto e di tutti, anche se non è possibile realizzarle per una serie di situazioni che condizionano e mortificano, nonostante si faccia in lui insistente il bisogno di credere e di sperare. Come in Ho sognato i miei sogni, dove evidenzia questo stato d’animo e, al tempo stesso, l’esigenza di creare presupposti al suo sperare, pur sapendo che il dubbio che tutto possa cadere nel vuoto non lo lascia per niente tranquillo. ·
Tempo presente rende certo quel dubbio. A niente vale la bellezza della sua terra e il mare · che «traduce l’azzurro del cielo». Sono realtà i morti ammazzati, e i giovani, che non hanno più esempi a cui modellarsi, non sono che «fantasmi della nostra coscienza»!
Sono qui a guardare
diamanti sparsi nell’acqua
Solo il rude profilo dei monti
nudi di roccia
nasconde una città che piange
i suoi morti.
La natura si fa partecipe dei sentimenti del poeta, e anch’ essa, come lui, appare pietrificata dinanzi a tanto spargimento di sangue. Siamo nel 1992, anno in cui c’erano state le stragi di Falcone e Borsellino. Cammarata, come tutti noi, era rimasto sconvolto, e lottato interiormente, da un lato, dall’amore per la terra d’origine, dall’ altro, per la sofferenza e il dolore di cui essa è scenario.
Se rileggiamo Tempo presente, non notiamo che questo: uno sconforto che si fa esso stesso coscienza ammonitrice, perché il poeta, come la natura che vede vanificata la sua bellezza, subisce e piange nel chiuso del suo io la realtà del momento, nonostante vorrebbe fosse diversa. Egli si rende conto che niente o poco può fare, se non c’è la collaborazione di tutti e, allora, è portato a constatare, impotente, la malvagia bruttura voluta da uno sparuto gruppo di suoi simili. Da qui prende significato, che si carica di particolare pregnanza, il termine «fantasma», tante volte usato da Cammarata, quando, aristotelicamente, dice questa triste realtà, a malincuore accettata.
I motivi, che in queste poesie affiorano, sono tutti ricollegabili alla produzione precedente, sia in prosa che in versi. La sofferenza, l’ accanirsi dell’ingiustizia, il bisogno di ritrovare in sé e negli altri il senso di un’umanità più profonda che dia luce ai nostri giorni, l’amore, la denuncia sociale, l’attaccamento alle proprie radici, sono tutti motivi profondamente sentiti, poeticamente ben sviluppati e resi in Dal buio della notte, Per dare colore al tempo e Violenza, oh cara!
Il tema del dolore, seppure presente, è vissuto ormai come un ricordo, affidato al passato, ma presente e vivo in quello degli altri, che soffrono e disperano.
Cari fantasmi del vecchio cortile!
Via Commenda ancora ci unisce
per come eravamo coi segni sul viso
per quelli che siamo
coi segni nel cuore.
Viviamo lontani un giorno diverso.
Stasera tornato tra voi
col volto bagnato da lacrime
e pioggia
grido nel buio la mia redenzione.
Vi lascio leggero con ignoto sorriso.
Appeso a quel muro
c’è l’altro fantasma di quel che ero io.
Ma Via Commenda, a Milano non è soltanto un ricordo della via crucis subita. Anche se il poeta dice: «grido nel buio la mia redenzione», egli non ha smesso di dimenticare e con partecipazione vive la sofferenza altrui.
Notate i versi («per come eravamo coi segni sul viso / per quelli che siamo coi segni nel cuore») uniti dall’anafora, una figura retorica ricorrente nella poesia di Cammarata, proprio perché lo aiuta a marcare certi aspetti del suo stato d’animo che diversamente potrebbero non essere evidenziati, e notate anche l’altro verso («Vi lascio leggero con ignoto sorriso»), dove, se l’aggettivo «leggero» dice la sua liberazione dal peso della malattia, l’altro che segue, «ignoto», riferito al sorriso, evidenzia la sua meraviglia per il nuovo che è in lui, per il sorriso, da cui da tempo era stato privato e, incredulo, ancora non si spiega. Sono versi che dicono la sofferenza del poeta per il dolore altrui, ma niente può fare, se non essere vicino a loro.
Le poesie, che vengono pubblicate nel libro Romano Cammarata e che pure registrano un continuum con le opere sopra citate, si caratterizzano per una maggiore presa di coscienza e per una marcata apertura agli altri. Ecco, ad es., Sotto la mia finestra e Piazza di Siena. Il poeta, alla primavera che avanza, vede aprirsi il cuore ed è portato a sperare ancora; oppure, pur essendo fisicamente lontano, sa ricrearsi «con gli occhi della mente» un posto di Roma a lui caro, ma per poco, perché il richiamo al reale è più forte e pressante. Per questo, si notino le accumulazioni dell’inizio (i luoghi, il verde, la folla, gli agili puledri, i cavalieri) e della fine (la sporcizia, il lavandino, i bidoni, la sedia).
Il sogno poi si spezza
come uno scheggiato specchio
e torno nell’angusto cortile
della Milano vecchia.
Ritrovo la sporcizia
il lavandino rotto
i bidoni della spazzatura
la sedia sgangherata su cui siedo
ma anch’io pago mi sento
e senza invidia.
C’è in queste poesie una piena consapevolezza, ma anche una determinazione
che diviene ancor più risoluta, come in Roma non far la stupida stasera:
E quando tornerò,
perché io tornerò,
sarò sul Gianicolo la sera
ad abbracciarti
con sguardo d’amore
Allora il dolore apre meglio alla vita e la fa amare ed apprezzare, pur con le ombre, che sono molte. A leggere questi versi c’è – dicevamo – consapevolezza, ma non accettazione passiva. Si legga Incontro con la luna. In qualche modo il poeta richiama Leopardi nell’atmosfera che sa creare e nel tono del suo discorrere (al pari del Recanatese, Cammarata discorre, e il discorrere è esso stesso un canto), non certo nel pensiero, perché il Nostro è corroborato da sano ottimismo.
Eppure, il motivo della morte è presente in Cammarata; è una presenza accetta, naturale, da cui nessuno è esente, che non annulla ed anzi è vista in una luce diversa, dato che gli uomini che hanno bene operato continuano a vivere nel ricordo degli altri. Concetto caro al Foscolo e ai romantici ottocenteschi, ma qui si colora di moderna sensibilità. Anche l’uomo comune, non solo l’uomo dotato di particolari doti, l’umile che vive dignitosamente nel rispetto degli altri e che è stato elargitore di nobili sentimenti, questi vivrà nel tempo («Vivo è chi sta nel cuore / nella memoria nostra»), ad onta degli incapaci, pur potenti, che già vivono la loro vita terrena nell’oblìo.
Il riferimento va a Ogni qualvolta torno, dove questo motivo riaffiora come sorgiva che tonifica la vita, mentre in altri componimenti è presente come realtà che accomuna i viventi. Come ne Il vischio.
Odoletta gioiosa, che ti specchi
nel sole del primo mattino,
guarda anche me
che nato sono a nuova vita
Dai anche a me
senza temere agguati
il tuo trillo festoso
Qui il poeta vuole essere partecipe della gioia che è nel creato, e viverla con intensità, fino a quando «il tempo cacciatore» glielo permetterà.
Altro motivo ricorrente è quello dell’ infanzia, di pretesto per ricordare luoghi, persone care o semplici oggetti che lo proiettano in quel mondo passato per sempre lontano e che solo la memoria, a sprazzi, riesce a recuperare.
Quale primavera fu la mia […]
Allora, nel cielo azzurro
oltre le nubi bianche c’era Dio
e a casa vicino al mandorlo
l’amore di mamma.
Basta un niente (una altura, la sconfinata campagna, il silenzio intorno) perché venga al poeta tutta una folla di pensieri che lo riporta, ma per un po’, ad un tempo ormai lontano. Eppure il ricordo è preciso, fermo, colto nell’atto di pascolare, di studiare la storia (e quale storia!) o nel rivedersi sul «mandorlo grande». E qui c’è da sottolineare una nota nostalgica: non è tanto quel mondo che l’Autore rimpiange, bensì lo stato innocenziale per sempre perduto e, ancora, la vigile presenza della madre, elargitrice di quella sicurezza che ora non ha.
Certo è che alla sua infanzia Cammarata lega sempre l’immagine della madre. In Ricordi in un cestino è il ricordo del cestino dei bottoni, che gli riporta la figura materna intenta a cucire, mentre lui bambino le giuoca accanto. Solo più tardi, quando non vedrà più il cestino, si renderà conto che lei se n’è andata «per non tornare più».
Se si considera il tenue filo che dà corpo a questo’ componimento e l’ effetto che esso raggiunge, dobbiamo dire che, padrone degli strumenti, il poeta abilmente ha saputo gestire la materia grezza, l’ha plasmata e le ha impresso una vita palpitante di luci e di colori che difficilmente dimenticheremo.
Ti ricordo, mamma,
seduta a rammendare
mentre a te vicino
ti stavo ad ascoltare
Era un cestino tondo
di paglia ricucita …
L’agilità, che è propria del verso breve (il componimento è costituito di senari e settenari con pochi quinari), qua e là qualche rima, le assonanze interne, le riprese delle immagini, raggiungono un risultato sorprendente che non sa né di barocchismo né di sentimentalismo, perché Cammarata esprime ciò che sente con spontaneità e, al tempo stesso, con sofferto distacco.
Altrove, come in Non ho radici, il ricordo della madre morta gli serve d’aggancio per ritornare idealmente alla terra di appartenenza. In questo componimento, come in altri, il poeta è preso dalla nostalgia, dal senso della lontananza, ma in ogni caso è sempre coerente nelle manifestazioni del suo animo, le quali ci appartengono, perché, filtrate dal fuoco vivo della poesia, non sono più manifestazioni d’un singolo individuo, ma patrimonio spirituale, in cui tutti ci rispecchiamo.
Non ho radici si rifà agli anni dell’infanzia, quando, per esigenze di lavoro, il padre, che era maestro, dovette portare con sé in Sardegna la famigliola. Sradicato dal suo ambiente, il piccolo Romano ne risentì tanto, cosa che si portò dietro per
sempre e che lo faceva gioire di una gioia che trasmetteva a chiunque ogni qualvolta doveva tornare in Sicilia.
Un albero può vivere senza radici
senza l’abbraccio caldo della terra?
Eppure non ho radici
ho la scorza cresciutami con gli anni
ho i rami contorti dal pensiero
ho le foglie che cadono coi sogni
Non ho radici
àncore nere affondate
tra la gente che è mia per stirpe
sulla terra che i miei avi tiene.
L’attacco, che di per sé presume una risposta negativa, sconfessato dall’avversativa «eppure», che, a sua volta, viene rafforzata dall’anafora, escluderebbe ogni legame, se non fosse per gli affetti profondi che legano
il poeta alla terra di appartenenza. Perciò, a ragione, dice:
In quei momenti
quando più s’aspira
a trovar pace e a dimenticare
sento che in fondo anch ‘io sono
vincolato
e lo sono ad un luogo che è lontano
tra i monti della Sicilia antica
dove attende un fiore
una parola cara
il corpo senza vita di mia madre.
Qui è la sicilianità di Romano Cammarata. Non qualcosa di astratto, non vuota dichiarazione di appartenenza che serve solo ad attestare su certe posizioni o ad imporre la propria opinione per l’autorità di cui si è investiti. La sicilianità di Cammarata è intrisa di sentimenti veri che gli vengono dettati dalla vicinanza spirituale che stabilisce con la sua isola e dall’essere partecipe degli eventi che, nel bene e nel male, fanno parlare della terra di Sicilia e la connotano rispetto alle altre.
Cammarata amò la Sicilia e la seguì, senza trascurare niente, nel suo evolversi, positivo o negativo che fosse; e questo fece sì che ne parlò e scrisse con distacco e competenza, dando la precedenza alla ragione più che a sentire le corde del cuore. In cambio, pur essendo lontano per ragioni di lavoro, egli s’interessò della Sicilia per farla uscire dal suo stato di chiusura secolare e per contribuire a migliorarla con la prassi e la parola.
Le liriche La miniera, La ballata del minatore, Il lavoro, se esaltano l’opera dell’uomo, frutto di mani incallite che «avanti le tende a mostrarle / con rabbia orgogliosa», denunciano lo sfruttamento a cui è sottoposto e rivendicano una giustizia che allevi la sofferenza e restituisca il sorriso a quanti lavorano nella
precarietà, ma anche dia loro la dignità di essere umani che, alla pari di altri, hanno diritto alla vita. Questo reclamano gli umili, e questo evidenzia Cammarata ne La miniera, dove uomini annaspano «della terra nelle viscere / a respirare silicio / a scontare di nuovo l’eterna pena», mentre i loro «bambini consapevoli di tutto / ora stavano lf piccoli adulti / a guardar fisso il pozzo della morte». Così, la poesia di Cammarata, denunciando, tende al riscatto sociale e si carica di una tensione che ridà voce ai più deboli nel nome del rispetto e della solidarietà umana.
Un motivo nuovo della poetica di Romano Cammarata è la guerra nei suoi aspetti più crudi. La prima guerra del Golfo, con le sue immagini di sterminio che entravano nelle nostre case per televisione, scioccò un po’ tutti e fece temere il mondo. Da qui prende spunto il lungo componimento Nato da un mistero, che, con un’andatura dialogica, rinnega ogni guerra, annullatrice di progresso, strumento di sterminio e di giustificazione «per altre guerre folli».
Invochi anche il progresso
ma ancora con convinzione
ancora per dominare
lasci morire di fame
milioni di persone
per poi sprecare ricchezze
per appagare da folle
un sogno di potenza.
Il poeta Cammarata, come Quasimodo e tanti che la guerra vissero, smette di cantare. Come si fa, dinanzi a tanta atrocità, a cantare? Qui il poeta, in tono dimesso, si appella al buon senso e alla ragione, pur rendendosi conto che a niente vale il raziocinio, se vengono a mancare i saldi principi che danno veramente senso alla vita.
Romano Cammarata è un osservatore attento, e la sua interlocutrice è la vita nelle sue sfaccettature. Questo gli permette di calarsi nella realtà e vederla con gli occhi di tutti per qualificarla e additarla per quella che essa è, senza sentimentalismi, che non sono della poesia, la quale, per essere tale, deve parlare al cuore di ogni uomo e in essa farlo riconoscere. Il poeta, con uno stile che è frutto di tante letture e di un intenso lavorio umano e spirituale, ha saputo darci con la sua opera una poesia che, prendendo linfa dalla migliore tradizione poetica italiana e straniera, è capace di suscitare fantasmi buoni per lenire la sofferenza ed aprire alla speranza quanti ad essa si accostano.
NOTE
1. R. Cammarata, Per dare colore al tempo, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1985.
2. R. Cammarata, Nel buio della notte, Armando Roma, 1983.
3. «Spiragli», A. IV, ottobre-dicembre 1992. Cfr. S. Vecchio, Romano Cammarata, Terzo Millennio, Caltanissetta, 2002.
Da “Spiragli”, anno XVI, n.1, 2005, pagg. 25-31.